Torna in libreria (Marsilio) il saggio di Pavel Florenskij, “Le porte regali”, che rivela due opposte forme di spiritualità nell’Europa orientale e occidentale. Un’analisi di Massimo Cacciari.

Tra le vere opere di Elémire Zolla sta certamente quella di averci fatto scoprire l’opera di Pavel Florenskij, promuovendo prima l’edizione di La colonna e il fondamento della verità presso Rusconi nel 1974 (prima traduzione nel mondo) e poi, presso Adelphi nel 1977, di Le porte regali. Opere fondamentali per il pensiero teologico e filosofico del Novecento, scaturite dall’irripetibile humus della apocalisse russa a cavallo della Rivoluzione. Non posso non ricordare con emozione anche il mio incontro con esse (e l’influenza determinante che ebbero per alcuni miei lavori, come Icone della legge e L’angelo necessario, precedenti il largo sviluppo di studi su Florenskij che negli ultimi trent’anni è maturato soprattutto in Italia, fino al recentissimo e importante volume collettivo curato da Silvano Tagliagambe, Il pensiero polifonico di Pavel Florenskij, presso l’University Press della Facoltà teologica della Sardegna).

La ristampa di Le porte regali, dopo molte adelphiane, avviene ora a cura e con una post-fazione di Grazia Marchianò, nell’ambito dell’edizione delle Opere Complete di Zolla, presso Marsilio. Occasione preziosa per approfondire ancora il valore epocale di questo saggio. Esso va ben oltre all’illuminare i fondamenti teologici dell’arte dell’icona russa del XV secolo, e del sommo Andrei Rublev in particolare, a partire dai suoi modelli bizantini (chiarendo così, retrospettivamente, anche aspetti decisivi di tutta l’arte paleocristiana). Le porte regali impongono una drammatica comparazione tra forme di civiltà, sulla differenza che sembra avere per sempre diviso la spiritualità dell’Europa orientale da quella occidentale. Una comparazione che in Florenskij diviene perentorio giudizio, quasi ad assumere la forma dell’aut-aut. Da una parte, l’opera che rivela, che apre il Velo e permette di intuire il Realissimo; dall’altra parte, l’Occhio sovrano del poietes, dell’artista-poeta, che dispone la sua materia secondo la sua prospettiva. Da una parte, l’opera che fa tutt’uno col culto; dall’altra, la creazione che si pretende libera, e che per Florenskij è invece incatenata, come i prigionieri della Caverna platonica, alla rappresentazione delle apparenze, delle ombre del Reale. L’icona vive sulla soglia, trova il proprio luogo appunto sull’iconostasi che distingue lo spazio dei fedeli dal sacro in sé inaccessibile. Nel mostrare l’abissale differenza tra i Due, l’icona è segno a un tempo dell’Invisibile stesso. Custode del mistero nel momento in cui lo esprime. Il mondo della sua immagine è puramente metafisico; l’immagine dell’icona è mundus imaginalis in sé, non in relazione a quello dell’esperienza sensibile.

È questo un destino dell’immagine e dell’immaginare da cui l’Occidente sembra separarsi per sempre con la grande svolta segnata da San Francesco, Cimabue, Giotto, Dante: qui la Luce taborica dell’Icona si incarna nella sofferenza, nel dramma storico delle figure fino a esserne inghiottita. E tuttavia Florenskij, grande teorico anche dell’arte dell’avanguardia russa, sa bene quale poderosa nostalgia per l’icona, per il suo pathos anti-soggettivo, anti-romantico, rinasca proprio nel Novecento! Le forme fondamentali in cui una civiltà si esprime difficilmente muoiono, scompaiono, piuttosto, e altrettanto imprevedibilmente possono in altri modi risorgere. Ciò fa di Le porte regali un testo imprescindibile anche per la filosofia dell’arte contemporanea.

Non si intenderebbe però l’importanza filosofica del grande saggio florenskijano se non lo si leggesse alla luce dell’idea di Verità svolta nel suo capolavoro, La colonna e il fondamento della verità. Non si conosce vera-mente se non divenendo uni-sostanziali all’altro, non semplicemente simili. Non vi è verità nella semplice corrispondenza tra forme dell’intelletto e l’apparire delle cose. Anzi, l’errore è già contenuto nel chiamare “cose”, e così reificare, gli essenti reali di cui facciamo esperienza. Conosciamo vera-mente soltanto il vivente che amiamo e di cui, amandolo, vogliamo partecipare in toto. La Verità integra, eterna, luminosa, sovra-luminosa si rivela soltanto quando, usciti dalla caverna dell’Io, amiamo il vivente amando Dio che è Amore. Questa idea di Verità, che ha origini neo-platoniche, e che Zolla pone giustamente in relazione con le grandi metafisiche dell’Iran, sembra essersi separata per sempre da quelle dominanti nell’Occidente, tutte, per Florenskij, nient’altro che rappresentazioni del nostro esserci storico (e perciò memoria o oblio di eventi temporalmente determinati). E tuttavia, di nuovo, come intendere nelle sue radici il nostro stesso destino se non comparandolo al paradigma che Florenskij gli oppone? Due civiltà, eppure entrambe appartenenti all’Europa o Cristianità. Un agon, una lotta nello stesso cuore? Questo mi sembra certo: che cessando tale lotta, cesserà di battere questo cuore. Evento che molti segni affermano già essersi compiuto.
Massimo Cacciari, filosofo di chiara fama, professore emerito e fondatore della Facoltà di Filosofia dell’Università San Raffaele di Milano.
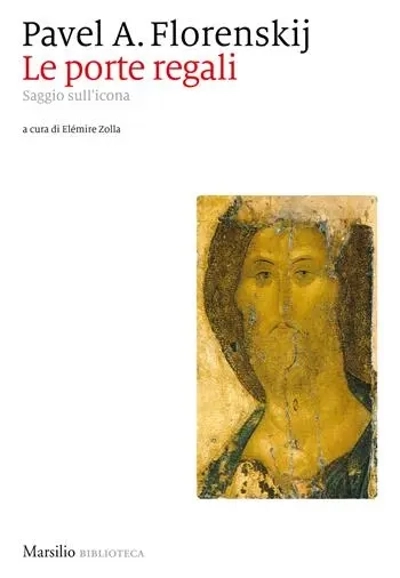
(L’articolo è stato pubblicato nella “Repubblica” del 22 giugno 2018, per gentile concessione)
Immagine di copertina
Andrej Rublëv, Icona della SS. Trinità, Mosca, Galleria Tret’jakov
La leggenda del cervo himalayano*
di Grazia Marchianò

In che stral di mia intenzione percuote
Dante, Paradiso XIII, 105
Il passo del Paradiso dantesco in cui l’intenzione è una freccia scoccata al bersaglio, esprime l’intento in questo libro di scrutare la finitudine nel suo logo-radice: quell’”interiorità” messa sotto scacco da uno scientismo incline a screditarla come il residuo clamoroso di un animismo primitivo. A fronte di questa supponenza, si fa strada invece la consapevolezza che proprio guardando intensamente lì dentro, veniamo scoprendo – nella ricchezza per lo più dissipata dell’energia interiore – non solo la disposizione ad accogliere le nostre singole finitudini senza disperazione, ma a d addestrarci all’uso migliore di ogni istante riuscendo a dilatare interiormente l’esperienza del tempo concesso in un mondo permeato di forze in parte imperscrutabili. Loro, le “forze” ricorrono a stratagemmi ingegnosi per ingabbiare, irretire, illudere: agiscono sul potente di turno e chi a mala pena sopravvive, su chi è nato senza nulla e chi invece è insediato su uno scranno, una cattedra, un soglio, un trono e deve difendere la reputazione di cui quello scranno, quella cattedra, quel soglio e quel trono non possono che alimentarsi per contrastare l’invincibile tendenza allo sgretolamento che in fisica si chiama entropia: un dis-ordine la cui interna “coerenza” è paurosamente maggiore di quella dell’ordine apparente.
Riaffermare l’importanza capitale dell’interiorità mettendo a fuoco il ruolo che le spetta nella travagliata esistenza comune è l’obiettivo al centro di una indagine irradiata in più direzioni, utile a chi sia disposto ad affacciarsi sull’interstizio tra un “fuori” sbadatamente scambiato per tutta la realtà e un “dentro” da cui ogni nostra esperienza proviene e ritorna. Se ciò suona al momento oscuro, soccorre un’antica leggenda himalayana dove gli effetti funesti della disattenzione al proprio “dentro” sono illustrati da una deliziosa metafora. Il muschio, una sostanza d’inebriante, sottile fragranza, si forma copiosa nella sacca addominale del cervo maschio, via via che l’animale raggiunge l’età adulta. Il profumo del muschio emanante lo eccita in misura dirompente. Alla cerca frenetica della fonte del profumo, vaga nella foresta annusando cortecce e fogliami, scontrando sui tronchi il suo palco di corna per giorni e settimane fino a sfinirsi. Come impazzito, ebbro di profumo che insegue fuori di sé, si slancia dal dirupo precipitando nel vuoto.
Chi al tavolo da gioco dell’esistenza punta tutte le sue carte sul “fuori” e ignora o trascura di avere dentro di sé le prerogative per riscattare l’inevitabilità della finitudine, assomiglia al cervo himalayano: una creatura sottomessa al “programma” di nascere per morire, esattamente come noi. Senonché la differenza tutta umana sta nel disporre di una “vista interiore” (insight) che se si accresce in trasparenza e acutezza con intenzione incrollabile, arriva a destare all’intrinseca connessione di mente e natura dove infatti “esterno” e “interno”, tangibile e astratto sono congiunti. Se ci si è definiti Sapiens (dal latino sapio, sàpere: “assaporare”, quindi “sapere”), non è per l’intelligenza, l’astuzia, la laboriosità condivisa dagli altri esseri senzienti ma per un ardore – i Greci lo chiamarono thumós – il cui impercettibile scatto di partenza è dentro di noi. Osservare questo “dentro” con la lucidità di chi analizza una colonia di batteri al microscopio e la simpatia verso il sistema che ci regge – ebbene lucidità e simpatia sono gli alleati giusti sia per chi vive una vita vorticosa nel “fuori”, sia per chi trascorre il suo tempo affidando alla meditazione, al pensiero e alla scrittura quel che è riuscito ad afferrare dell’intreccio (in fisica quantistica si chiama entaglement) tra il “dentro” della materia e il “dentro” della mente. Riuscire ad esprimere questo intreccio in una pur modesta operazione di scrittura procura, ammetto, un certo scoramento. L’ideale sarebbe di persuadere senza annoiare, di allietare con la delicatezza di un arpeggio, di commuovere come il gesto gratuitamente gentile rivoltoci da uno sconosciuto di passaggio o come la grazia indifferente di un gatto che ci salta in grembo su una panchina, accoglie le carezze e se ne va. L’obiettivo che ha più contato per me nella vita e nella scrittura è stato di approssimarmi alla persuasione. Per l’esperienza che ne ho fatto, essa non ha il sapore aspro di un frutto acerbo e l’aura di chi ha voltato le spalle al mondo, al contrario aiuta a cogliere la potenza di sentirsi vivi, una potenza alla quale l’ardore di Carlo Michelstaedter, temo, non resse.
Quando lui, giovanissimo, si buttò a capofitto negli studi di filologia e filosofia classica cimentandosi coi concetti maggiori del pensiero greco fra i quali peitho, la “persuasione”, forse non è scorretto attribuire all’umore melanconico (atrabile nel lessico alchemico) del geniale goriziano la spinta a sostenere che peitho «è il tentativo, sempre vanificato dalla manchevolezza irriducibile della vita, di giungere al possesso di sé stessi». «Persuaso – scriveva nella sua tesi di laurea – è chi ha in sé la vita». Viene di pensare che il giorno in cui decise di sottrarvisi, Carlo non ebbe accanto qualcuno a ricordargli: «[…] la vita è cosa di tanto piccolo rilievo che l’uomo in quanto a sé, non dovrebbe essere molto sollecito né di ritenerla né di lasciarla». Così Leopardi nelle Operette morali faceva dire a Plotino venuto in soccorso dell’amico Porfirio deciso a morire:
Ora ti prego caramente, Porfirio mio […], lascia cotesto pensiero: non voler essere cagione di questo gran dolore degli amici tuoi buoni, che ti amano con tutta ‘anima […]. Vogli piuttosto aiutarci a sofferir la vita […]. E quando la morte verrà, allora non ci dorremo […], e ci rallegrerà il pensiero che, poi che saremo spenti, essi [gli amici e i compagni] ci ricorderanno, e ci ameranno ancora.
[….]
*(Interiorità e finitudine: La coscienza in cammino. Orizzonti eurasiatici, Ed. Rosenberg&Seller, Eranos Foundation, 2022)

Grazia Marchianò, pensatrice e saggista, professore emerito di Estetica e Storia e Civiltà dell’Asia Orientale all’Università di Siena-Arezzo e Dottore honoris causa presso la Open University di Edinburgo per il suo contributo agli East-West Studies, ha svolto ricerche sul campo in India e in Giappone, mettendo a confronto le culture orientali e quelle occidentali. Lunghi soggiorni di ricerca in India e un periodo immersivo in un monastero buddista in Giappone costella un cammino condiviso per un quarto di secolo con il marito Elémire Zolla di cui Marchianò ha curato e analizzato i volumi dell’Opera omnia presso l’editore Marsilio. Nel 2022 ha donato la biblioteca e l’archivio privato zolliani all’Accademia Vivarium Novum, Villa Falconieri di Frascati.
Autrice di molti saggi e testi accademici, sia in lingua italiana che inglese, tra i suoi libri figurano: La parola e la forma (Dedalo); L’armonia estetica (Dedalo); Il codice della forma; Interiorità e finitudine: la coscienza in cammino (Rosenberg & Sellier); Sugli Orienti del pensiero (Rubbettino). Ha curato e tradotto libri presso gli editori Dedalo, Guerini, Rubbettino, Istituti Poligrafici Internazionali, Edizioni di Storia e Letteratura, Guida, Red, SE e Rizzoli. In campo estetico Machianò ha curato l’edizione italiana delle opere di Ananda Kentish Coomaraswamy, “La trasfigurazione della natura nell’arte” (Rusconi) e “Perché esporre le opere d’arte? in La filosofia dell’arte cristiana e orientale (Rusconi).
Ha diretto collane di estetica comparata e orientalistica presso svariati editori italiani e internazionali ed è stata autrice di una prolifica produzione editoriale su estetica, filosofia e religioni orientali. Come estetologa e orientalista era presidente onorario dell’Associazione Italiana Studi di Estetica (AISE).
Dopo la morte della scrittrice Cristina Campo, pseudonimo di Vittoria Maria Angelica Marcella Cristina Guerrini (1923-1977), Elémire Zolla e Grazia Marchianò andarono a vivere insieme a Roma e nel 1980 di unirono in matrimonio civile. Nel decennio successivo presero casa a Montepulciano, nella Valdichiana senese.
La scomparsa è avvenuta nella sua abitazione di Montepulciano.
